Visita alla città di Castelfranco Veneto
- Simone De Santi

- 8 giu 2017
- Tempo di lettura: 12 min

Visita Turistica del Centro Storico di Castelfranco Veneto
Un po' di storia
Castelfranco Veneto deve il proprio nome al castello ‘franco’ (esente) da imposte per i suoi primi abitanti-difensori. Il possente quadrato di rossi mattoni fu eretto sopra un preesistente terrapieno, alla fine del XII, dal Comune medievale di Treviso, poco a nord del villaggio della Pieve Nova, sulla sponda orientale del torrente Muson, a presidio del turbolento confine verso le terre padovane e vicentine.
Già nei primi decenni del Trecento, sul lato orientale (borgo Treviso – la parte opposta di dove ci troviamo ora), si sviluppa il primo nucleo dell’abitato (Bastia Vecchia), strumento anch’esso di difesa, dotato di un ospizio per poveri e viandanti.
Città murata per sua stessa definizione, conserva quasi integralmente la cinta muraria e le sei torri che si innalzano ai quattro angoli e nei punti mediani di oriente e meridione. Castelfranco Veneto lega indissolubilmente i suoi ottocento anni di storia alla strategica posizione nel Veneto centrale, tappa obbligatoria tra Venezia, la Germania e le Fiandre, tra l’Europa occidentale e le pianure dell’Est. Città di commerci fin dall’origine e sede di un antico mercato di granaglie e bestiami, attivo sino alla metà del secolo scorso; fu centro, in passato, delle più svariate attività artigianali e snodo ferroviario di primo livello dalla fine dell’ottocento ai giorni nostri.
Il castello, a pianta quadrilatera (circa 230metri di lato) fu eretto a partire dalla fine del sec.XII e completato nei decenni successivi. Delle originarie otto torri, restano le quattro d’angolo, la torre dei morti, edificata nel 1246, a metà della cortina di meridione.
Le mura, le torri e il fossato sono quanto rimane di una complessa macchina da guerra, allestita, secondo la tradizione, alla fine del secolo XII, ma sottoposta a completamenti e rinforzi durante tutto il secolo XIII.
Per prime si innalzarono le quattro torri d’angolo, cui seguirono le mura. Al castello si accedeva attraverso due porte (“di Treviso”, a est, e “di Cittadella”, a ovest), provviste di sarasineshe e ponti levatoi (sostituiti nel XVI secolo da ponti in muratura), e da due “posterle” (accessi pedonali), uno a sud, l’altro a nord.
Le mura, alte circa 17m e spesse circa 1.70m, sono prive di fondazione. Poggiano, infatti, su un basamento realizzato con la tecnica della muratura a sacco (ciottoli di fiume, frammenti di mattoni e calce spenta al momento dell’impasto), la stessa tecnica utilizzata per le mura (paramenti di mattoni solo sulle facce esterne ed interne). Il camminamento di ronda (dove si è conservato) sporge per 1.75m, sostenuto da archetti appoggiati su mensole di pietra.
Dal 24 gennaio 1339 al 12 maggio 1797, Castelfranco fu dominio veneziano. La guerra di Cambrai (1509-1517) svela l’inadeguatezza militare del castello, incapace di reggere alle nuove tecniche di assedio e ai tiri di artiglieria. Si abbattono o crollano alcuni tratti di mura; i terrapieni esterni sono ridotti a coltura dai privati.
Piazza Giorgione
Nell’Ottocento, il castello, sfuggito alla demolizione (progettata alla fine del secolo precedente), assurge a simbolo della città. Mura e torri si trasformano in apparato scenografico urbano. Tra il 1865 e il 1869, si rifanno il ponti della Salata (di fronte alla torre civica) e dei Beghi (verso il mercato), si costruiscono il passeggio, intitolato a Dante, e i giardini pubblici sul lato verso la torre di nord-est, detta di Giorgione.
La piazza del mercato (ora piazza Giorgione) fu la sede per il raduno del bestiame al venerdì, per cui era fornita di tre pozzi. Ha i portici davanti alle case. Rara è la sua ampiezza, per essere piazza di una città di origine medioevale. Ancor oggi, le mattine del martedì e del venerdì è sede di vivacissimi mercati. Assieme al corso della bastia nuova è il cuore della città. Ad ovest la villa Andretta costituisce il fondale della piazza; di fronte a questa vi era il mercato dei maiali.
Frutta e verdura erano collocate lungo la bastia nuova fino al “Ponte della salata”. Il lato opposto è concluso dall’acqua del Musonello, dai pubblici giardini e dalle mura del castello. Il Palazzo Piacentini (portici accanto al Bar Borsa) divenne presto “l’Hosteria della Spada”, celebre per frequenza di forestieri e mercanti. La sua facciata ha affreschi del sec.XVI.
Il mercato fu saggiamente governato dalla Repubblica Veneta. Nel 1420 fu eretto un porticato per la protezione delle biade, detto il “Paveion”. Una serie di iscrizioni lapidarie testimonia l’importanza dell’edificio “ad publicum semper usum”.
Il Giorgione
Giorgione, nome con cui è noto il pittore Giorgio da Castelfranco (Castelfranco Veneto, 1478 circa –Venezia, 1510), è stato un pittore italiano della scuola veneta.
Nonostante la grande popolarità dell'artista ancora in vita, la sua è una delle figure più enigmatiche della storia della pittura. Non ha firmato alcuna opera e la ricostruzione del suo catalogo, nonché la determinazione dei significati iconografici di molte sue opere, è oggetto di numerose controversie e dibattiti tra gli studiosi. Fu attivo sulla scena pittorica veneziana per poco più di dieci anni, segnando un'apparizione repentina ma sfolgorante, che nella storiografia artistica ha poi assunto proporzioni leggendarie.
Anche restringendo al massimo il suo catalogo e volendo ridimensionare i commenti iperbolici che seguirono la sua morte, la sua attività segnò sicuramente una svolta epocale nella pittura veneta, imprimendo una decisiva svolta verso la "Maniera Moderna".
"Giorgione" era il soprannome legato probabilmente alla sua alta statura fisica. Giorgione stesso fu comunque sfuggente, inafferrabile e misterioso: a Gabriele D'Annunzio appariva "piuttosto come un mito che come un uomo". Il monumento al grande pittore è stato innalzato nel 1878.
Costeggiate ora il Muson e arrivate al semaforo. Attraversate la strada e prendete per Borgo Treviso
Borgo Treviso
Palazzo Riccati; edificio settecentesco con elegante colonnato rifatto nel 1908 per trasformarlo in scuola. É stato per alcuni anni una delle sedi storiche dell’Istituto alberghiero, in cui si trovavano le aule per gli studenti di quarta e di quinta. Gli spazi sono stati successivamente abbandonati per motivi di sicurezza.
Accanto si trova lo stabile della Pro-Loco, il punto info-turismo di Castelfranco Veneto, ospitato nell’antico Palazzetto Colonna Preti, costruito nel XVI secolo e restaurato all’interno con radicali modifiche nel XVIII secolo.
Tra Palazzo Riccati e la Pro Loco, c’è l’ingresso laterale della chiesa di San Giacomo Apostolo, edificio della prima metà del 1700. L'edificio fa parte del complesso, progettato dal Massari, che comprende anche l'interessante chiostro, edificato sull'area che già fu del Pio Ospedale di San Giacomo, conosciuto come Chiostro dei Serviti. Nella chiesa restaurata nel 2004, sono stati riportati all’antico splendore una rappresentazione di S. Giacomo Apostolo per ricordare che sin dalle sue origini la struttura di accoglienza per malati è stata dedicata a questo Santo, rappresentato con la veste del pellegrino, e nel pavimento due lucernai individuano alcuni affreschi risalenti all’anno mille. Entrare da quella porta per la visita. Uscire da quella principale e visitare il chiostro a destra (oggi una delle sedi del conservatorio di musica di Castelfranco).
Proseguite il cammino fino all'ingresso di Villa Revedin Bolasco
Villa Revedin Bolasco
Il conte F. Revedin eresse sui resti di due preesistenti palazzi decadenti, tra il 1852 e il 1865, la propria residenza affidando il progetto all’architetto G.B. Meduna.
Il cortile nobile della villa di forma rettangolare costituisce il raccordo tra la parte dominicale, le due ali e la scuderia. Nell’aprile del 1865 le sale del palazzo, affrescate da G. Casa, furono aperte a sontuose feste. Il pittore che allestì la grande sala da ballo affrescò sui soffitti uno squarcio di cielo dove raffigurò Il trionfo della musica e la danza delle ore
Il Meduna realizzò un elegante scalone, in forma di nastro, che si allaccia, tramite una loggia, alla mezza circonferenza del soffitto, trapunto a ventaglio. Revedin ordinò che i cavalli avessero dodici stalli con singoli canestri per il fieno e vasche di marmo, creando con fiera ostinazione una scuderia di rara bellezza. Il giardino venne creato alla maniera inglese, realizzando canali, laghi e collinette. Numerose varietà di specie vegetali, buona parte esotiche, arricchirono gli oltre 80.000 mq del Parco.
I Rinaldi, subentrati nella proprietà ai Revedin, affidarono all’architetto Antonio Caregaro Negrin l’incarico di proseguire la sistemazione del Parco. Egli eresse su un’isoletta del lago la preziosa serra arcuata in stile moresco, in posizione obliqua rispetto alla facciata della villa, e nel 1878 creò la loggetta ottagonale con tetto a pagoda, slanciata nell’alto da un acutissimo stelo. Le statue di O. Marinali (XVII secolo), provenienti dall’ antico giardino dei Corner, furono raccolte in un anfiteatro costruito per la cavallerizza.
Il parco, uno dei più belli e romantici del Veneto occupa un’area di oltre 80.000 metri quadrati e include, fra l’altro, un laghetto, rilievi artificiali del terreno, statue, vari edifici e l’ ”arena”; che era non un teatro all’aperto, come si crede, bensì un maneggio. Solo il Parco è oggi aperto al pubblico in particolari giornate o su richiesta, per informazioni rivolgersi al Museo Casa Giorgione, sito all'interno delle mura.
Da questo punto, proseguendo lungo Viale Brigata Cesare Battisti, si raggiunge la stazione ferroviaria di Castelfranco.
Tornate ora indietro lungo lo stesso percorso, Borgo Treviso e via Riccati. Attraversate la strada e fermatevi nella zona pedonale di Corso XXIX Aprile, adiacente la Torre Civica
Torre Civica
Corso XXIX Aprile, la via principale della città, è delimitata a est dagli edifici della Bastia Nuova, sbarramento di case edificate nel XIII secolo per aumentare la difesa di Porta Franca (davanti), fulcro della fortezza. A partire dal XV secolo le abitazioni di legno fecero posto agli edifici in muratura con porticato.
Guardando i Palazzetti su Corso XXIX Aprile, da sinistra a destra: prima del semaforo è il Palazzo Pulcheri, ora Bordignon Favero (sec. XVIII), accanto si trova Palazzo Soranzo Novello, dello stesso periodo, il quale presenta una elegante struttura architettonica ed è arricchito da raffinate decorazioni in stucco: nelle sue sale sono conservate tele di S. Ricci (XVIII secolo) e di L. Carlevarjis (XVIII secolo); il Palazzo è riconoscibile dal grande stemma sulla facciata; oltre il semaforo, verso destra, Palazzo Spinelli Guidozzi, sulla cui facciata sono rappresentate le vicende di Diana e Atteone e del Ratto di Europa in un ricco complesso decorativo attribuito alla scuola del Veronese. L’edificio è posto al centro della città di fronte alla Torre Civica. Poco più avanti, oltre le arcate, si trova La facciata di Palazzo Bovolini Soranzo è affrescato con le fatiche di Ercole, di scuola mantegnesca di fine XV secolo.
I giardini, le mura di levante, il fossato e il Passeggio Dante, circondato da statue, donano al luogo un tocco di raffinata bellezza.
La Torre Civica di Castelfranco costituisce la parte più nobile e rilevante della complessa struttura fortificata eretta a cavallo tra XII e XIII secolo dal Comune di Treviso come estremo baluardo difensivo occidentale della Marca Trevigiana, a contrasto delle brame espansive delle vicine Padova e Vicenza.
La Torre, che si erige a metà della cortina muraria orientale, è detta anche “Torre Davanti” o “Torre Franca”, poiché sovrasta la porta che guarda alla città fondatrice e introduce all’asse viario che, partendo da Borgo Treviso, porta al capoluogo della Marca.
La Torre in origine era di altezza non superiore a quelle d’angolo, come testimonia la traccia ancora riscontrabile tra la tessitura muraria originaria e quella delle successive aggiunte; e soltanto con la collocazione della cella campanaria, all’inizio della dominazione veneziana (1339), raggiunse gli attuali 43 metri di altezza.
La Torre Civica - che riporta traccia delle diverse dominazioni in età medievale, a cominciare dai grandi affreschi sulla volta della porta d’ingresso alla città, con le effigi dei Carraresi sotto la volta della torre stessa – era una sorta di fortificazione nella fortificazione; un baluardo estremo che nei primi secoli di storia di Castelfranco dava rifugio ai rappresentanti del governo e alla loro guarnigione.
In facciata la torre presenta sul lato esterno il grande quadrante azzurro dell’orologio, sormontato dal leone di San Marco col libro aperto (simbolo di pace), voluto dal Podestà Pietro Gradenigo nel 1499.
Oggi la torre è affiancata da due edifici di pubblico utilizzo, costruiti sulle mura stesse del castello; guardandola, a sinistra l’Hotel alla Torre e a destra il Ristorante Pizzeria alla Torre.
Attraversate ora i giardini pubblici a ridosso della cinta muraria. Attraverso una delle due “posterle” il ponte del mercato, immettetevi su via Garibaldi e proseguite per alcuni metri verso l'interno del castello.
Conservatorio Statale di Musica
Da via Garibaldi, si accede, attraverso la cancellata che porta al conservatorio, a Casa Barbarella, poi Angaran (sec. XVI) , attuale sede del Conservatorio di musica "Agostino Steffani": alcuni studiosi ritengono fondata la tradizione che lega il nome di Giorgione alla nobile famiglia Barbarella, anche se i documenti sull'argomento sono ancora oggetto di discussione e gran parte della biografia dell'artista rimane avvolta nel mistero. La palazzina, eretta direttamente sulle mura interne di Castelfranco, è un ambiente scenografico naturale utilizzato più volte per rappresentazioni teatrali e concertistiche.
Proseguendo lungo il giardino del conservatorio, si esce in vicolo del Paradiso. A pochi passi si trova la Casa Costanzo, forse di impianto trecentesco (residenza del podestà prima del 1410), fu posseduta e abitata da Tuzio Costanzo, committente della Pala, venuto da Cipro a Castelfranco nel 1475. I caratteri gotici dell'edificio si leggono nella trifora ad archi ogivali polilobati della facciata, ornata dall'arma Costanzo in pietra. Nel salone del piano nobile sono affrescati gli stemmi dei Costanzo e dei Verni di Maiorca, il casato della moglie di Tuzio, e due raffinate fasce parietali: una dipinta su fondo rosso scuro nella quale, tra fogliami e volute, si contrappongono due figure femminili nude; l'altra, su fondo giallo oro, con cavalli marini alati, leoni e sirene tra fogliami.
Proseguite a ritroso, lungo via del Paradiso e tornate su via Garibaldi
Teatro Accademico
Il Teatro, progettato intorno al 1746 da Francesco Maria Preti per ospitare riunioni della Società degli Accademici, e costruito tra il 1754 e il 1780, considerato uno dei teatri più belli d’Italia. Nel corso del XIX secolo fu sede dell’Accademia dei Filogolotti e verso la metà del secolo fu ristrutturato.
L’originalità dell’edificio consiste nella sua duplice funzione di teatro diurno (per le riunioni degli Accademici) e notturno (per rappresentazioni teatrali) e nella sua ottimale acustica raggiunta mediante l’applicazione della regola della media armonica proporzionale.
Tutto l’interno, nel progetto originario di Francesco Maria Preti, risponde a canoni matematici: il quadrato della platea, il semicerchio dei palchetti, il cubo della sala, i rettangoli uguali delle logge e del proscenio.
Nel corso della ristrutturazione ottocentesca (promotore il conte Francesco Revedin), si eliminò l’originario zoccolo a bugnato rustico, si rettificò la linea sinusoidale delle tre file sovrapposte di palchi e si rifece il soffitto, affrescato dal pittore Sebastiano Santi con l’allegoria raffigurante L’immortalità assisa tra la Virtù e la Gloria che dispensa serti di alloro e letterati, scienziati ed artisti nati a Castelfranco. Il 9 ottobre 1858, la sala, rinnovata nelle forme attuali, fu solennemente inaugurata dal Trovatore di Giuseppe Verdi.
ORARIO VISITE: Martedì, Mercoledì e Giovedì ore 08.30-12.30.
Proseguite su via Garibaldi fino a Piazza San Liberale
La piazza porta il nome di San Liberale, patrono di Treviso e di Castelfranco Veneto, che si festeggia il 27 aprile. Sulla piazza si affacciano, il Duomo, intitolato a San Liberale e Santa Maria Assunta; il Municipio; la Biblioteca e il Museo Casa Giorgione.
Museo Casa Giorgione
Adiacente al Duomo si trova la casa Marta-Pellizzari, più comunemente conosciuta come Casa di Giorgione, non per una sicura appartenenza al maestro ma per la presenza al primo piano di un affresco a lui attribuito: il Fregio delle arti liberali e meccaniche. L’edificio, il cui nucleo originario risale al XIV secolo (ampliato tra XV e XVI), conserva fregi decorativi cinquecenteschi e alcuni affreschi con scene bibliche e di paesaggio riferibili alla scuola veronesiana del XVI secolo.
La Biblioteca
L’attuale palazzo del Monte di Pietà, progettato dall’ingegnere Luigi Benini di Castelfranco, risale al 1825-1826. A metà ‘800, la povertà dilagante nella città e nel territorio impose la costruzione di nuovi magazzini ove depositare il numero sempre crescente di pegni non preziosi (suppellettili domestiche, indumenti, ecc.).
Tra il 1865 e il 1869, su progetto dell’architetto Michele Fapanni, si edificarono le ali e la casa del custode che chiude, ad ovest, la corte interna.
Restaurato in tre diverse fasi, il palazzo ospita dal 1965 la Biblioteca Comunale, ricca di oltre 100.000 volumi, tra cui numerose opere rare e di pregio. Alla Biblioteca è annesso l’Archivio Storico Comunale (circa 7.000 volumi, registri e buste, risalenti al periodo compreso tra il sec. XV e il 1950).
Il Municipio
Al centro del castello, il Palazzo municipale, costruito tra il 1879 e il 1880, sorge sul luogo della quattrocentesca residenza del podestà veneziano. Sotto il portico del Municipio si apre l’Oratorio della Beata Vergine delle Grazie.
Il Duomo
La chiesa è l’opera prima dell’architetto Francesco Maria Preti, ma anche l’opera riassuntiva e più alta della sua vasta produzione progettuale, nella quale sono espresse tutte le sue teorie architettoniche, successivamente riprese in altre chiese della zona. Il Preti assume come modello di riferimento la palladiana chiesa del Redentore di Venezia e fors’anche la veneziana chiesa dei Gesuiti.
La costruzione del Duomo non comportò solo la demolizione di un tratto di cinta muraria, ma anche l’abbattimento dell’antica chiesa romanica “di dentro”, sacrario di memorie storiche cittadine, irrimediabilmente perdute insieme all’originaria cappella Costanzo.
Oltre alla Pala di Giorgione, il Duomo conserva numerose opere d’arte. Tra le altre: la pala del coro, con la Discesa di Cristo al limbo di Giovanni Battista Ponchini (circa 1500 -1570), collaboratore del Veronese, e, al lato destro, il Martirio di S. Sebastiano di Palma il Giovane (1544-1628), l’altare dell’Assunta (abside della crociera) dello scultore Giuseppe Bernardi detto il Torretto (1694 -1773).
Nella stupenda quadreria della Sacrestia si possono ammirare sette frammenti degli affreschi che Paolo Caliari detto il Veronese (1528-1588) eseguì per la villa Soranza di Treville, demolita all’inizio dell’Ottocento
Pala del Giorgione
La Pala di Castelfranco è un dipinto a tempera su tavola di pioppo (200x152 cm) di Giorgione, databile al 1503-1504 circa, e conservato nella sua collocazione originaria nel Duomo di Castelfranco Veneto. La straordinarietà dell'opera, che tanta influenza ebbe nell'arte veneta successiva, è data anche dal fatto che si tratta dell'unica pala d'altare realizzata dall'artista.
Fu commissionata dal condottiero della Repubblica Veneta, Tuzio Costanzo, per la cappella di famiglia nel duomo di Castelfranco, in occasione della morte del figlio Matteo, occorsa tra la primavera del 1504 e l'estate del 1505 nel corso di una campagna militare.
Il dipinto raffigura la Madonna col Bambino su un alto trono, a sua volta sopra un basamento che poggia su un sarcofago di porfido, con lo stemma della famiglia Costanzo. Probabilmente la volontà di far rivolgere uno sguardo triste e assorto al reale sarcofago, che idealmente racchiudeva il figlio morto del committente, condizionò l'organizzazione iconografica della scena, creando quella che potrebbe essere definita come un'altissima piramide, con al vertice la testa della Vergine e alla base i due santi che si trovano in basso davanti ad un parapetto: a destra Francesco e a sinistra Nicasio.
Terminata la visita, concedetevi una meritata pausa in uno dei molti locali del centro per il classico aperitivo o un calice di Prosecco.
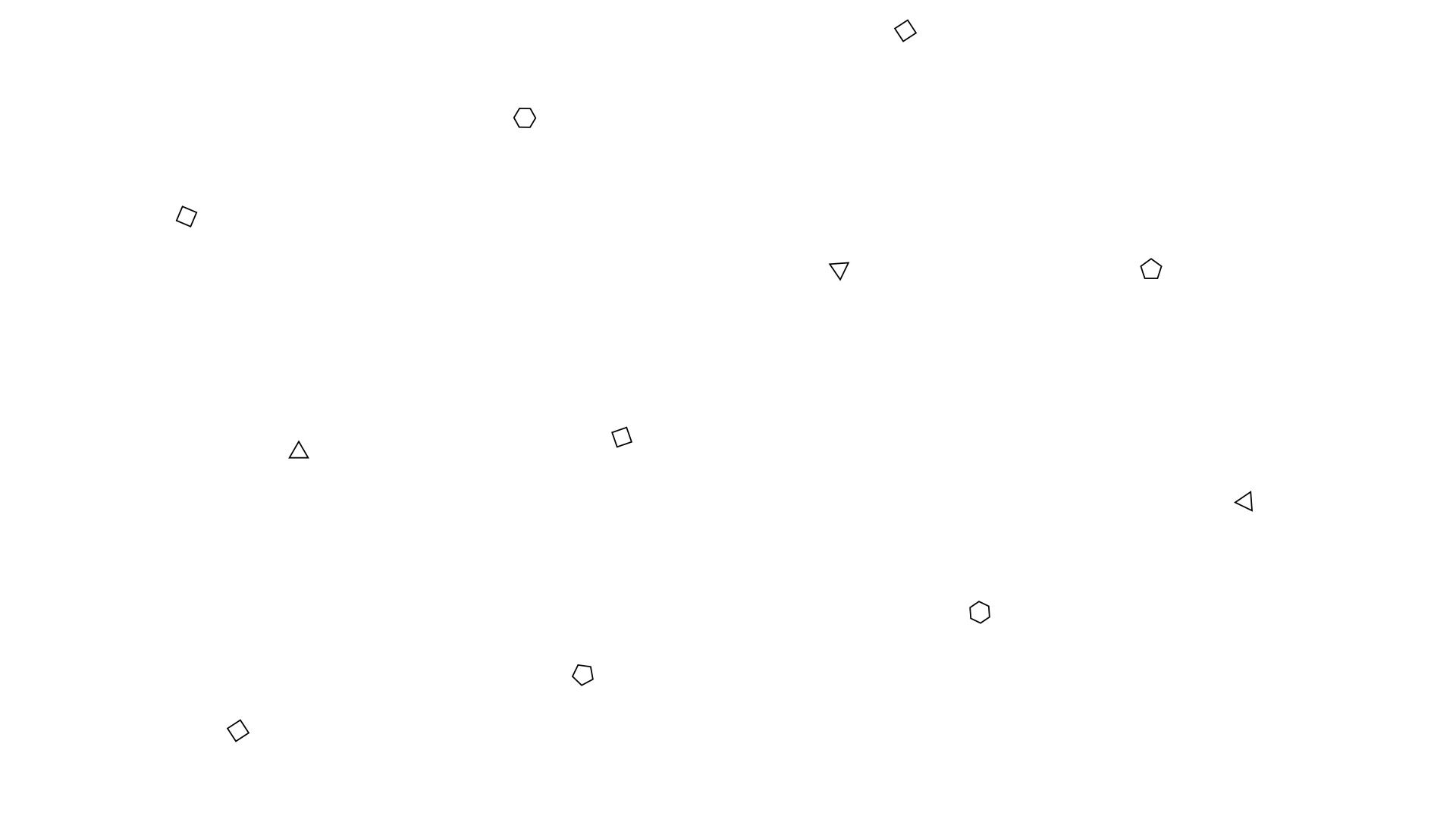
Commenti